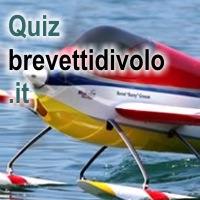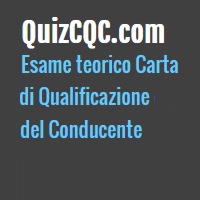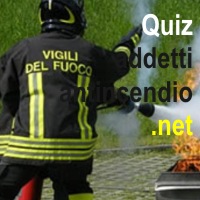|
038..:: 26.10.2013

Nella foto, la soprano, Luciana Distante.
Proseguiamo questo «percorso musicale» a
cura di Luciana Distante, soprano. E' una iniziativa
dell'Assodolab riservata a coloro che amano la "buona
musica" e gli "autori del passato" che ci accompagnerà per tutto l'anno 2013 su
queste pagine web del nostro Supplemento di informazione
on-line
www.lasestaprovinciapugliese.it
La prossima uscita sarà il prossimo sabato.
La Redazione
Prof. Agostino Del Buono
Regione Puglia, LECCE..:: Rigoletto rappresenta un
punto di svolta sia dal punto di vista poetico che
stilistico nella produzione verdiana; è un’opera spartiacque
che si pone tra opera e dramma cioè tra i canoni
tradizionali codificati da Rossini e una nuova concezione
del teatro in musica.
Le strutture classiche dell’opera italiana di primo
Ottocento erano basate sull’integrazione tra azione e
riflessione, tra sezioni cinetiche e sezioni statiche in
nome di un continuum musicale. Queste strutture di
ascendenza rossiniana vengono riprese da Verdi sin
dall’inizio della sua carriera operistica, ma è a partire da
Rigoletto che esse assolvono a una nuova esigenza artistica:
la centralità della vicenda drammatica. Questa nuova
esigenza porta Verdi a utilizzare le strutture classiche in
una maniera nuova poiché esse all’occorrenza vengono
giustificate drammaturgicamente.
“Le roi s’amuse” di Victor Hugo da cui l’opera è tratta,
rappresenta nella storia della cultura europea una nuova
idea di teatro inteso come specchio della realtà, fusione di
grottesco e sublime, tragedia e commedia, in altri termini
di una dimensione ambivalente dell’essere umano. Pertanto
nella scelta del soggetto è racchiusa già una presa di
posizione: Verdi, aderendo a questi orientamenti estetici,
trova nell’innovazione del soggetto l’impulso per uno
svecchiamento delle convenzioni del melodramma italiano.
Rigoletto è un personaggio complesso, dotato di un
sorprendente spessore psicologico, e Verdi, nel trattarlo in
musica, si rende conto che non basta “accomodare” le
strutture chiuse, se necessario bisogna romperle. Per
rispondere a questa necessità il compositore lascia spazio
alla parola, usa il declamato per esprimere la doppia natura
del personaggio, buffone crudele alla corte di Mantova e
allo stesso tempo padre affettuoso di Gilda. Questa doppia
natura del protagonista, si riflette nella dualità
interno-esterno, giorno-notte della scena. Le nuove
soluzioni apportate da Verdi sembrano avvicinarlo al dramma
musicale wagneriano; nonostante la distanza tra la
tradizione italiana e quella tedesca è possibile riscontrare
una convergenza nel dato empirico.
Verdi, mediante l’uso dei temi ricorrenti, assesta l’unità
drammaturgica e questo procedimento sembra avvicinare il
compositore italiano alla tecnica del leitmotiv wagneriano
con la differenza che non si tratta di temi conduttori che
stendono sull’intera opera una serie di riflessioni
musicali, ma di procedimenti microstrutturali che uniscono
il prima e il dopo della partitura, ricordi e presagi allo
stesso tempo. Tema musicale ricorrente per eccellenza è la
maledizione che mediante precisi richiami o allusioni,
traccia un arco concettuale che si stende lungo tutta
l’opera.
La celebre e giocosa aria del Duca “La donna è mobile”
esplode in tutta la carica drammatica quando ritorna nel
finale dell’opera ad annunciarci che la tragedia tanto
temuta, si è inevitabilmente consumata: il contrasto
fortissimo tra dramma e ilarità, assurge in tutta la sua
prepotenza. L’esempio appena riportato mostra anche come
Verdi ottenga certi effetti con semplicità e immediatezza;
l’orecchiabilità di quest’aria permette al pubblico di
intuire all’istante l’avvenuta tragedia.
Lo stesso non si può dire dei leitmotiv wagneriani poiché
essi sono accessibili a un pubblico colto musicalmente. Un
altro elemento che avvicina Rigoletto al dramma è la
strumentazione, a volte l’orchestra assume un ruolo tematico
indipendente verso le voci che dialogano per definirne lo
stato d’animo, ad esempio nel tema scattante che contorna
l’incontro di Rigoletto e Gilda nel primo atto “Figlia, Mio
padre”. Le necessità drammatiche spingono Verdi ad aumentare
la complessità e la funzione intrecciata della
strumentazione e nel potenziare il ruolo dell’orchestra
Verdi si avvicina al compositore tedesco che mirava a una
più stretta relazione tra l’elemento melodico e quello
sinfonico.
Rigoletto tra opera e dramma dunque, poiché seppure l’opera
presenta una struttura sostanzialmente classica, la
centralità della vicenda drammatica e la stretta aderenza
tra azione e musica conducono a soluzioni simili a quelle di
una tradizione musicale distante da quella italiana: il
dramma musicale wagneriano.
Luciana Distante

..::
www.laformazionemusicale.it
|