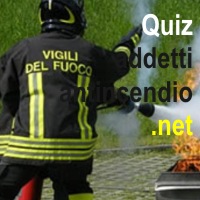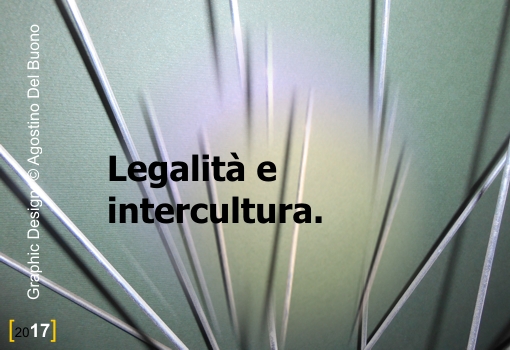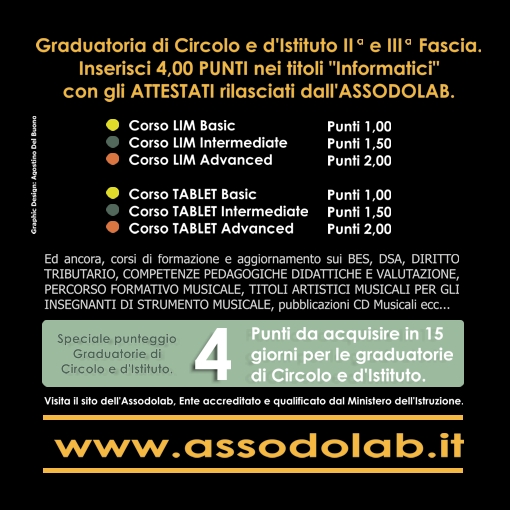|
023 ..:: 20.02.2017 :: 18:30
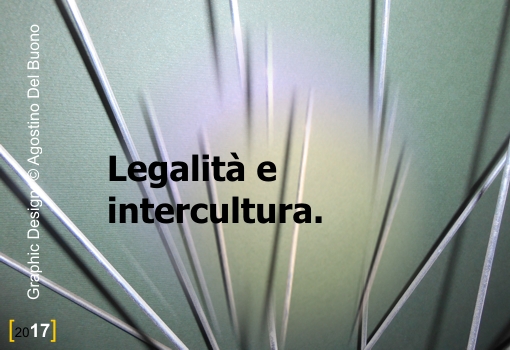
:::
SOVERATO :: Quella in cui viviamo è una società complessa,
multiculturale e globalizzata, dove i mutamenti sociali
hanno posto in discussione i precedenti assetti, le finalità
e gli scopi perseguiti dalle istituzioni scolastiche nel
recente passato. Tale dinamismo culturale acquista un ruolo
sempre più strategico in riferimento anche al fenomeno dei
flussi migratori di dimensione planetaria che, in ogni
latitudine del pianeta, rendono la demografia sempre più
eterogenea. In questo “villaggio globale” (Mc Luhan), la
convivenza e l’integrazione fra popoli e culture basate sul
riconoscimento dei diritti umani sono nuovi campi di ricerca
e di studio, ma anche nuovi valori, nuovi paradigmi : sono
lontani da una logica di assimilazione, e sono volti a
valorizzare la dignità e la ricchezza di ogni cultura. Al
problema delle diversità linguistico-culturali, sono
connesse molte delle domande cruciali, delle sfide e dei
paradossi che l’Europa è chiamata ad affrontare nel suo
cammino verso la progressiva integrazione (linguistica,
culturale, valoriale, istituzionale, politica) interna: è un
percorso necessario, “condicio sine qua non” di una
democratizzazione più adeguata ai nuovi complessi panorami
planetari. Bauman ha individuato nella nostra società le
connotazioni di una “industria dello smaltimento dei rifiuti
umani “ che scarica ed espelle gli scarti che residuano dai
processi di trasformazione planetaria, inutili, da
eliminare. L’ineguaglianza sociale, economica e politica e
la mancanza di equità si sono rivelate fattori
destabilizzante e radici di conflitto, come osservava nel
2000 Kofi Annan, segretario delle Nazioni Unite. Solo
attivando un processo formativo di smantellamento dei
pregiudizi e di organizzazione flessibile dell’accoglienza
si può ostacolare l’insorgere di pericolose idee di
intolleranza.
I saperi di Morin “Insegnare l’identità terrestre” e
“insegnare la comprensione” risultano ancora oggi molto
utili, al fine dell’acquisizione della piena consapevolezza
della società multiculturale e multietnica. Secondo
Vernadski l’uomo ha compreso per la prima volta di essere un
abitante del pianeta e, pertanto, agisce e pensa in maniera
planetaria. Già Bloom individuava nel “comprendere” uno dei
macro obiettivi. In questo contesto generale l’educazione
deve sensibilizzare al valore dell’etica della tolleranza e
della comprensione planetaria, facendo sviluppare ad ogni
suo utente la propria coscienza antropologica .
Dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam, la politica in materia di immigrazione è
diventata un ambito in cui l'Unione europea ha una piena
responsabilità. La mobilità e lo scambio fanno parte
integrante del «programma di lavoro dettagliato sul
monitoraggio degli obiettivi dei sistemi di istruzione e
formazione in Europa», approvato dai capi di Stato o dai
governi. (Consiglio Europeo di Barcellona 2002). Nei
documenti ufficiali dell’ONU e dell’Unesco ci sono
dichiarazioni ufficiali che invitano gli Stati a realizzare
un modello di educazione che tenga conto del valore della
multuculturalità e della plurietnia. Pare opportuno, dunque,
affermare che a fronte di questa società multiculturale e
plurietnica può essere prefigurata una “pedagogia
interculturale” che, rigettando ogni forma di staticità e
gerarchizzazione fra le culture, nonché di chiusura e
cristallizzazione, promuova invece il dialogo.
La sfida della scuola dell’autonomia diventa, così, proprio
quella di coniugare l’analisi e la sintesi, quindi coniugare
le esigenze globali e sovranazionali con quelle
specificamente localistiche.
La problematica dell’integrazione interculturale è stata
oggetto di attenzione e preoccupazione da parte dei diversi
legislatori sin dal 1991 con la legge n.176 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989), nel 1990 con la C.M.
n. 205 del 26 luglio 1990: “La scuola dell'obbligo e gli
alunni stranieri. L'educazione interculturale” e ancora con
la C.M. n. 73 del 2 marzo 1994: “Dialogo interculturale e
convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola”.
Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,
riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in
vigore in materia, e la Legge n. 40/98 focalizza gli aspetti
organizzativi della scuola circa l’insegnamento
dell’italiano come seconda lingua, il mantenimento della
lingua e cultura di origine, la formazione dei docenti e
l’integrazione sociale.
La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003,
contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di
tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani
di studio per la costruzione di percorsi educativi e
didattici appropriati a ciascuno studente.
Nelle “Indicazioni Nazionali per la scuola primaria”(2004)
si evince che i bambini del primo ciclo sono già pronti a
riconoscere a sé la dignità di persona e a riconoscerla agli
altri. La disponibilità affettiva, psicologica,
intellettuale e relazionale del ragazzo è una risorsa
educativa per gli insegnanti, a vantaggio dell’ educazione
interculturale. Appare chiaro, d’altronde, con la Circolare
Ministeriale n. 24 del 1° marzo 2006 e le “Linee Guida”
(Nota n. 829 del 16 febbraio 2006), che la presenza di
studenti con radici culturali diverse sia un fenomeno ormai
strutturale, non più episodico, e che debba trasformarsi in
opportunità per tutti. L'effettività del diritto allo studio
è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali.
Infine, il Documento Ministeriale 2007: "La via italiana per
la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni
stranieri" sottolinea la complementarietà di linee di azione
che comprendano l’integrazione degli allievi stranieri e la
prospettiva di cambio interculturale.
Nelle Indicazioni per il Curricolo (2007) si evince che
alcune discipline, come la geografia e la musica
costituiscono strumenti potenti per favorire e sviluppare
processi di educazione interculturale. Le istituzioni
scolastiche si avvaleranno di occasioni formative
differenziate supplementari, laboratori linguistici,
presenza di mediatori culturali, attuazione di specifiche
modalità di valutazione, approfondimenti sulla cultura degli
alunni, dossier per la comunicazione scuola . Rimane
fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno
secondo l’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99).
L’immersione (full immersion), in un contesto di seconda
lingua parlata da adulti e compagni, facilita
l’apprendimento del linguaggio funzionale.
Di recente le scuole italiane hanno colto le opportunità
offerte da strumenti destinati a trasformare il tradizionale
modo di fare scuola come le lavagne interattive multimediali
.
La LIM offre un contributo straordinario alla costruzione di
un ambiente di apprendimento interculturale e di una
comunità di pratica adeguata alla società della conoscenza:
sviluppa una didattica centrata sullo studente e sui suoi
bisogni; favorisce la metaconoscenza negli studenti sempre
più protagonisti e costruttori del loro sapere; sperimenta
nuovi modi di rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi
(libri, contenuti digitali, ecc…)
Degni di menzione risultano, a tal proposito, i documenti
europei, che individuano le abilità trasversali o
“macrocompetenze“ indispensabili all’uomo che deve
affrontare le sfide della società conoscitiva e complessa
del 21° secolo.
Le “Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio
del 2006” elaborano otto “competenze chiave” per
l’apprendimento permanente (life long learning) necessarie
allo sviluppo personale, alla cittadinanza attiva e
all’inclusione sociale tra cui la comunicazione nella
madrelingua; la comunicazione nelle lingue straniere;
competenze interpersonali, interculturali e sociali e
competenza civica; La normativa italiana ha proseguito sulla
stessa linea:l’anno successivo alle Raccomandazioni europee,
nel Regolamento dell’obbligo Fioroni stabilisce le otto
competenze chiave della cittadinanza attiva: imparare ad
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare,
agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed
interpretare l’informazione.
Nella stessa ottica si colloca l’indagine ISFOL che
individua le competenze trasversali nelle abilità di
diagnosi, di comunicazione, di decisione, di problem
solving. Il Consiglio dell’Unione Europea, nelle conclusioni
del 12 maggio 2009 (ET 2020), muove dalla consapevolezza che
per affrontare le sfide attuali e future è fondamentale una
cooperazione europea basata sul metodo di coordinamento
aperto (MCA).
L’Europa prosegue nella ricerca di senso e significati
dell’educazione: nelle Conclusioni del Consiglio (11 maggio
2010) sulla dimensione sociale dell'istruzione e della
formazione si promuovono il ruolo dell'istruzione e della
formazione quali strumenti chiave per il conseguimento
dell'inclusione sociale: l’intento è di contrastare
eventuali tendenze alla marginalizzazione culturale; puntare
sull'acquisizione delle competenze di base fondamentali, in
particolare nel caso di alunni provenienti da un contesto
migratorio.
Il Sistema d’Istruzione italiano sta ancora al passo con
l’Europa con una normativa mirata e coerente.
Ma perché questa prospettiva possa affermarsi in modo
capillare e diffusa è necessario un mirato piano di
formazione rivolta soprattutto a docenti e a dirigenti
scolastici, oltre a predisporre materiali ad uso didattico
concepiti con questa logica. Inserire le macrocompetenze
sistematicamente nei processi didattici quali strumenti di
reale integrazione e inclusione e promuovere in tutta la
scuola un ethos della formazione è la fase operativa che
necessita di un reale e incisivo sostegno.
L’ azione propulsiva del DS nei confronti dei docenti e dei
genitori è determinante nell’attivazione di percorsi
interculturali e plurilinguistici adeguati ai bisogni
formativi. Il DS avrà particolare cura di promuovere
progetti coerenti con i più aggiornati esiti della ricerca
scientifica, pedagogica e disciplinare, organizzare piani di
formazione in servizio in materia di minoranze linguistiche,
rivolti a docenti. (CCNL 2006/09 ART. 19). Grazie al ruolo,
alle funzioni e alle responsabilità assegnategli dal
D.lgs.165/01 e dal D.lgs 150/09, e dall’autonomia funzionale
regolamentata dal D P R 275/99 ai sensi della L.n.59/97,
egli favorirà una serie di iniziative volte all’accoglienza
e alla realizzazione di attività interculturali efficaci. In
clima di federalismo amministrativo e politico
istituzionale, la parola chiave sarà “sussidiarietà”
verticale e orizzontale (Riforma costituzionale, Art. 117 e
Art. 118) “Condicio sine qua non” sarà il concorso plurimo,
differenziato e convergente dell’apporto di più contesti:
formali, non formali ed informali. Il DS, abilissimo
negoziatore, instaura e coordina rapporti fecondi con i
soggetti istituzionali e non, presenti sul territorio,
soprattutto con quelle istituzioni in grado di offrire
rilevanti opportunità sul versante della formazione.
Pertanto, l’attuazione dell’uguaglianza (art 2 e 3della
Costituzione ), nel rispetto delle differenze di tutti e
dell’identità di ciascuno,diventa un obiettivo primario del
DS e richiede l’impegno di tutti gli operatori della scuola
ma anche e soprattutto l’integrazione fra scuola e
territorio tramite un’ ottima progettazione formativa
integrata .
Ovviamente, in primis, sarà necessario interloquire
all’interno dell’istituzione scolastica con gli operatori
quali il DSGA, i collaboratori e i docenti incaricati delle
funzioni strumentali. Al fine di migliorare la qualità della
scuola e, al contempo, renderla più competitiva e più
“attraente”, Il DS si propone come obiettivo quello di
potenziare la comprensione e produzione della lingua
italiana e di attuare un clima di confronto e dialogo tra le
diverse culture al fine di creare un ambiente propulsivo di
cultura, di democrazia, di valori condivisi di cittadinanza,
di libertà. La crescita e la valorizzazione della persona
umana si perseguono secondo percorsi formativi rispondenti
alle attitudini di ciascuno e finalizzate al pieno successo
formativo, offrendo pari opportunità e curando tutti i suoi
aspetti :cognitivi, affettivi, relazionali, etici e
religiosi.
L’apporto del nuovo insegnanento “Cittadinanza e
Costituzione “ (legge 30.10.2008 n. 169), sarà notevole :
offre l’occasione per una messa a punto del fondamentale
rapporto che lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto
di vista della sua legittimazione, sia dal punto di vista
del compito educativo ad essa affidato. Le scuole sono
chiamate in proposito a concorrere, anzitutto con la
riflessione, con l’approfondimento dei problemi e con la
sperimentazione, a questa messa a punto, in vista di un più
maturo assetto ordinamentale della materia.
Il Ds è tenuto, quindi, ad adottare strategie e decisioni
idonee e coerenti, sia amministrativo-gestionali, quanto
pedagogico-didattiche e controllare, altresi’, la qualità
dei processi formativi in atto.
L’attività negoziale del dirigente scolastico, prevista
dall’Art.33 del D.I. n. 44/01, prevede, infatti, la stipula
di accordi, intese, protocolli e convenzioni, adesione a
reti di scuole o consorzi, partecipazione della scuola ad
iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,
enti, università, associazioni socio-artistico-culturali, di
volontariato, la parrocchia, il tribunale dei minori, l’ASP,
la Prefettura, il consultorio, enti pubblici e privati,
profit e non profit, biblioteche, quindi tutti gli
“stakeholders con cui l’istituzione scolastica si relaziona.
Promuoverà l’ accesso a risorse economiche mediante apposite
forme di progettazione (Piani FSE, Progetti di cui all’art.
9 del del CCNL/2007- aree a rischio). Si preoccuperà di
motivare il personale docente e non docente coinvolto
attraverso la condivisione della mission. Attraverso un
modello organizzativo si definiranno ruoli funzioni e
responsabilità per la realizzazione dell’accoglienza e
l’integrazione sin dal momento dell’iscrizione.
Preoccupazione prioritaria del DS dovrà essere anche la
formazione del personale della scuola al riguardo
dell’integrazione interculturale. (CCNL 2006/09 ART. 19)
Ultima tappa sarà il controllo della qualità dei processi
formativi in atto.
Nell’ottica di una valorizzazione delle civiltà e dei valori
umani universali, questi approcci e strumenti didattici
saranno rivolti alla comunità scolastica e non
esclusivamente agli allievi appartenenti alle minoranze. E’
la promozione di questa “cultura di rete” basata su nuove
forme di comunicazione tecnologica che configurano il DS
come web-editor, e gli consentono di comunicare con gli
utenti all’interno e verso l’esterno dell’istituzione
scolastica, favorendo una diversa modalità di approccio al
territorio. In ultima analisi il suo compito si sostanzierà,
in questo ambito, nel promuovere, socializzare e diffondere
il valore dell’INTERCULTURA ,connesso allo studio delle
condizioni ritenute migliori per favorirne lo sviluppo.
Quella in cui viviamo è una società complessa,
multiculturale e globalizzata, dove i mutamenti sociali
hanno posto in discussione i precedenti assetti, le finalità
e gli scopi perseguiti dalle istituzioni scolastiche nel
recente passato. Tale dinamismo culturale acquista un ruolo
sempre più strategico in riferimento anche al fenomeno dei
flussi migratori di dimensione planetaria che, in ogni
latitudine del pianeta, rendono la demografia sempre più
eterogenea. In questo “villaggio globale” (Mc Luhan), la
convivenza e l’integrazione fra popoli e culture basate sul
riconoscimento dei diritti umani sono nuovi campi di ricerca
e di studio, ma anche nuovi valori, nuovi paradigmi : sono
lontani da una logica di assimilazione, e sono volti a
valorizzare la dignità e la ricchezza di ogni cultura. Al
problema delle diversità linguistico-culturali, sono
connesse molte delle domande cruciali, delle sfide e dei
paradossi che l’Europa è chiamata ad affrontare nel suo
cammino verso la progressiva integrazione (linguistica,
culturale, valoriale, istituzionale, politica) interna: è un
percorso necessario, “condicio sine qua non” di una
democratizzazione più adeguata ai nuovi complessi panorami
planetari. Bauman ha individuato nella nostra società le
connotazioni di una “industria dello smaltimento dei rifiuti
umani “ che scarica ed espelle gli scarti che residuano dai
processi di trasformazione planetaria, inutili, da
eliminare. L’ineguaglianza sociale, economica e politica e
la mancanza di equità si sono rivelate fattori
destabilizzante e radici di conflitto, come osservava nel
2000 Kofi Annan, segretario delle Nazioni Unite. Solo
attivando un processo formativo di smantellamento dei
pregiudizi e di organizzazione flessibile dell’accoglienza
si può ostacolare l’insorgere di pericolose idee di
intolleranza.
I saperi di Morin “Insegnare l’identità terrestre” e
“insegnare la comprensione” risultano ancora oggi molto
utili, al fine dell’acquisizione della piena consapevolezza
della società multiculturale e multietnica. Secondo
Vernadski l’uomo ha compreso per la prima volta di essere un
abitante del pianeta e, pertanto, agisce e pensa in maniera
planetaria. Già Bloom individuava nel “comprendere” uno dei
macro obiettivi . In questo contesto generale l’educazione
deve sensibilizzare al valore dell’etica della tolleranza e
della comprensione planetaria, facendo sviluppare ad ogni
suo utente la propria coscienza antropologica.
Dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato
di Amsterdam, la politica in materia di immigrazione è
diventata un ambito in cui l'Unione europea ha una piena
responsabilità. La mobilità e lo scambio fanno parte
integrante del «programma di lavoro dettagliato sul
monitoraggio degli obiettivi dei sistemi di istruzione e
formazione in Europa», approvato dai capi di Stato o dai
governi. (Consiglio Europeo di Barcellona 2002). . Nei
documenti ufficiali dell’ONU e dell’Unesco ci sono
dichiarazioni ufficiali che invitano gli Stati a realizzare
un modello di educazione che tenga conto del valore della
multuculturalità e della plurietnia. Pare opportuno, dunque,
affermare che a fronte di questa società multiculturale e
plurietnica può essere prefigurata una “pedagogia
interculturale” che, rigettando ogni forma di staticità e
gerarchizzazione fra le culture, nonché di chiusura e
cristallizzazione, promuova invece il dialogo.
La sfida della scuola dell’autonomia diventa, così, proprio
quella di coniugare l’analisi e la sintesi, quindi coniugare
le esigenze globali e sovranazionali con quelle
specificamente localistiche.
La problematica dell’integrazione interculturale è stata
oggetto di attenzione e preoccupazione da parte dei diversi
legislatori sin dal 1991 con la legge n.176 ( Ratifica ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989 ), nel 1990 con la C.M.
n. 205 del 26 luglio 1990: “La scuola dell'obbligo e gli
alunni stranieri . L'educazione interculturale” e ancora con
la C.M. n. 73 del 2 marzo 1994: “Dialogo interculturale e
convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola”.
Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,
riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in
vigore in materia, e la Legge n. 40/98 focalizza gli aspetti
organizzativi della scuola circa l’insegnamento
dell’italiano come seconda lingua, il mantenimento della
lingua e cultura di origine, la formazione dei docenti e
l’integrazione sociale.
La legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003,
contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di
tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani
di studio per la costruzione di percorsi educativi e
didattici appropriati a ciascuno studente.
Marfa
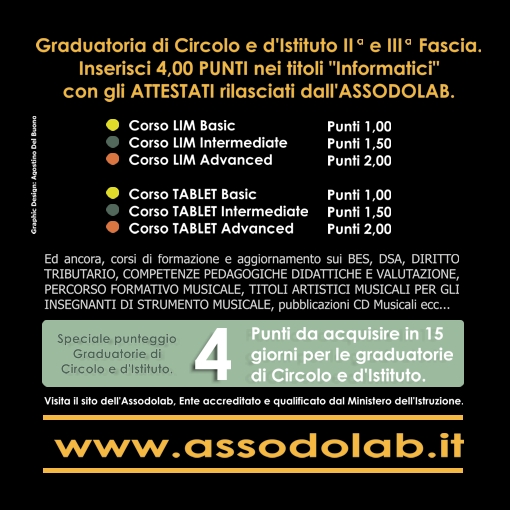
|